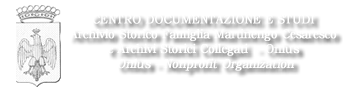Ultima stesura: copyright 2018.
Charlotte O. Vallino, Francesco Negri Arnoldi, Augusto Goletti
Il ritratto del conte Cesare Martinengo, opera di Girolamo da Romano detto Il Romanino
Questo quadro della Pinacoteca di Brera di Milano, in deposito presso la Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia, opera di Girolamo da Romano detto Il Romanino, ritrae il conte Cesare Martinengo, illustre Bresciano, la cui nascita era certamente avvenuta prima del 27 Giugno 1478 e la cui morte fu il 13 Ottobre 1527.
Si precisa che, nelle fonti abitualmente in circolazione, la sua nascita è generalmente collocata nell’anno 1477: ciò risale essenzialmente al libro sui Martinengo (tutti loro rami inclusi) di Monsignor Paolo Guerrini, apparso nel 1930, in cui egli scriveva che il conte Cesare Martinengo era nato a Brescia “verso il 1477”. (nota 1)
I documenti dell'Archivio della casata non citano mai tale anno, ma informano invece solamente che Cesare Martinengo era già nato quando il proprio padre, Giorgio Martinengo, aveva fatto testamento il 27 Giugno 1478: essi non danno però notizia su quale fosse la sua età in tale data. Non è pertanto possibile stabilire quando egli nacque esattamente: poteva essere avvenuto anche prima del 1477, come pure poteva essere avvenuto a ridosso della data del testamento suddetto. L'anno 1477 è pertanto da non citare.
Sempre dall’Archivio della casata, grazie a una annotazione del Cancelliere di famiglia di allora, si apprende che la sua morte cadde nella notte del 13 Ottobre 1527.
La data della morte del conte Cesare è fondamentale per orientarsi nella datazione dello splendido ritratto del Romanino.
Nel web, per esempio, esso viene sovente datato al 1540 circa. Tale anno non può essere tuttavia considerato appropriato quando lo si riferisca al conte Cesare Martinengo, come detto indiscutibilmente deceduto nel 1527. (nota 2)
Anche fonti più tradizionali, sempre in riferimento al ritratto del Romanino, citano date erronee per la cronologia della vita del conte Cesare. Di queste si discuterà più in là nel presente articolo.
Il personaggio ritratto dal Romanino aveva ricevuto il proprio prenome dal nonno paterno, quel Cesare Martinengo (a sua volta figlio di Ghirado Martinengo) nato verosimilmente sul principio del Quindicesimo secolo e morto verosimilmente all'inizio dell’anno 1460, basandosi su quanto si ricava dall’Archivio della casata.
Era un uomo assai reputato nell'arte della guerra e sagace in politica, grande possidente terriero e feudatario. Ebbe una carriera militare presso grandi potenze del tempo che l’Archivio della casata consente di ricostruire nelle fasi principali, al centro delle quali vi è la data 1432 (15 Aprile) quando il Doge Francesco Foscari gli concedeva in Feudo nobile, per la sua qualità di fedelissimo condottiero, la terra di Orzi Vecchi con suoi diritti e giurisdizioni.
Per maggiori informazioni sulla carriera militare del primo Cesare Martinengo della casata si invia il Lettore al saggio dedicato a Fortunato Martinengo firmato dagli autori del presente articolo, visibile in questo Sito. (nota 3)
Come informa l'Archivio della casata, egli sposò Orsolina (Orsola), figlia di Antonio d'Arco, al principio del 1434. La coppia ebbe una figliolanza di otto nati viventi, tra cui Giorgio Martinengo da cui sarebbe nato il Cesare ritratto dal Romanino del quale si tratta qui.
Una precisazione è fondamentale.
Sovente, le fonti citano il cognome Martinengo Cesaresco, attribuendolo anche al conte Cesare ritratto dal Romanino. Ma non è esatto dal punto di vista storico e araldico.
Infatti, come dimostrato il modo inoppugnabile dall’Archivio della casata, è proprio dalla grande fama personale acquisita dal conte Cesare (quello ritratto dal Romanino), che derivò l'uso di indicare la sua discendenza con il doppio cognome Martinengo Cesaresco, seppure solo a partire dalla fine del Sedicesimo secolo.
Egli aveva sposato Ippolita Gambara, una giovane anch’essa appartenente a una potente casata bresciana.
Rispetto al proprio nonno e al proprio genitore egli aveva ulteriormente ampliato il patrimonio familiare con l'acquisto di vasti latifondi e beni immobili di città, aveva assunto un ruolo di primo piano nell'organizzazione agricola del territorio bresciano ma anche nel campo dell'architettura. Tutto ciò aveva rafforzato il suo peso politico.
Valente nell’arte delle armi e sottile uomo politico, pur avendo prestato servizio sin da giovanissimo per la Serenissima aveva poi acquisito prestigio presso re Luigi XII di Francia - Duca di Milano -, diventandone Consigliere e Ciambellano. La sua lealtà al monarca francese e la sua azione durante la di lui conquista nel Nord Italia valsero che, nel 1509, l’antico feudo della casata, Orzivecchi, fosse elevavo a contea e che gli fosse attribuito il titolo di conte di Orzivecchi, non soltanto a lui riservato ma pure a tutti i suoi discendenti.
La trascrizione del documento del 1509 dal quale si apprendono tali fatti, redatto nel Francese dell’inizio del Sedicesimo secolo, è riportata nel saggio firmato dagli autori del presente articolo, poco sopra ricordato, visibile in questo Sito. (nota 4)
Come l'Archiviodella casata documenta chiaramente, il conte Cesare Martinengo, la sua numerosa figliolanza (venti tra figlie e figli nati viventi e di cui si abbia memoria archivistica), nonché i suoi nipoti, continuarono a usare il cognome Martinengo.
Il cognome Martinengo Cesaresco si sarebbe affermato successivamente, lentamente e non sistematicamente, onde differenziare la discendenza di questa specifica casata dagli altri numerosi rami di Martinengo che si erano sviluppati a partire dal Quattordicesimo secolo. L’appellativo Cesaresco, cognomizzato, derivava dal prestigio del conte Cesare, continuava a conservarne la memoria dando lustro alle generazioni che da lui discendevano.
Per completezza, occorre fare un'altra precisazione.
L’Archivio della casata dimostra come non sia corretta la notizia che si riscontra nella bibliografia contemporanea: quella che sostiene che il conte Cesare Martinengo fosse «chiamato il Magnifico». Lo aveva affermato senza esitazione Monsignor Paolo Guerrini, nel suo libro Una celebre famiglia lombarda apparso nel 1930. Ma tale epiteto, che aveva l’evidente funzione di enfatizzare le caratteristiche rilevanti del personaggio cui veniva attribuito, non fu riservato al conte Cesare Martinengo, ma era stato impiegato anche in precedenza per qualificare il di lui nonno e il di lui padre, come pure vari altri membri della casata stessa. Si trattò cioè di un appellativo elogiativo ricorrente.
Maggiori informazioni su tale questione, ricavate dall’Archivio della casata, sono presenti nel saggio nel saggio firmato dagli autori del presente articolo, poco sopra ricordato, visibile in questo Sito
Per quanto riguarda il ritratto del Romanino, senza voler entrare nel merito di questioni di attribuzione, è utile fare riferimento ai dati archivistici a disposizione grazie all’Archivio della casata.
Si può affermare che, in tale ritratto, il conte Cesare mostra una fisicità e tratti del volto ancora vigorosi, con la capigliatura visibile ancora scura e che guarnisce i lati del viso fuoriuscendo dall'elegante copricapo, con la barba solo in parte imbiancata: elementi che suggeriscono quella che allora poteva dirsi una età media, verosimilmente collocabile all'inizio degli anni 1520.
È da escludere che il ritratto fosse stato eseguito in relazione alla titolatura di conte di Orzi Vecchi, attribuita al conte Cesare Martinengo da re Luigi XII di Francia nel 1509. All’epoca egli aveva superato i trent’anni.
Una tale possibilità non è da prendere in considerazione e non soltanto per via dell’aspetto del conte Cesare che nel ritratto in questione non appare un trentenne ma un uomo più maturo. Un altro fatto che si propone di considerare è che, attorno al 1509, Girolamo da Romano era ancora giovane e le opere del suo primo periodo di produzione artistica non sono collegabili allo stile del ritratto del conte Cesare Martinengo. (Nota 5) Infine, è necessario tener presente che, nel ritratto che si sta commentando, il conte Cesare sfoggiava la collana d'oro con medaglione recante l'emblema di San Marco che non può, evidentemente, essere messo in relazione con l’onore ricevuto dal monarca francese proprio date le azioni avverse a Venezia ch’egli aveva portato avanti nel Nord Italia.
Il grandissimo riconoscimento ricevuto nel 1509 dal conte Cesare Martinengo veniva invece posto in chiara evidenza in un'incisione seicentesca che lo raffigura. (Nota 6)
Vi si notano elementi del volto che possono essere collegati con il ritratto del Romanino, che verosimilmente ispirò tale incisione.
Si potrebbe forse pensare che, nel Sedicesimo secolo, si ponesse in rapporto la data del 1509 con il ritratto del Romanino stesso?
È già stato osservato che alcune notizie riguardanti la cronologia della vita del conte Cesare Martinengo, riportate da fonti storiche e storico-artistiche, sono inesatte: questo può conseguentemente influenzare le ipotesi sulla datazione del dipinto del Romanino e sul periodo artistico in cui l’opera fu creata.
In una pubblicazione del 1965, ad esempio, viene detto che il dipinto è caratteristico del periodo attorno al 1550. (Nota 7)
Il dipinto dovrebbe allora essere inserito nella produzione degli ultimi lustri della vita dell'Artista.
Una tale data può essere posta in relazione con abbigliamento dominato dal nero, foggia del copricapo, chiarore e taglio del colletto, postura del volto, del Ritratto di Carlo V seduto, di Tiziano, datato 1548 (Alte Pinakothek, Monaco di Baviera)? In ogni caso l’effetto dell’abbigliamento del conte Cesare Martinengo risulta, per l’intervento estetico impressionante dell’insieme delle parti in pelliccia fulva che risaltano eccezionalmente sul nero, completamente differente.
Ma il grande problema di una datazione quale il 1550 circa risiede nel fatto che la pubblicazione in questione la collega a un anno della morte del conte Cesare errato: il 1551. (Nota 8)
Il conte Cesare Martinengo, che aveva fatto testamento rogato il 2 Settembre 1527, era morto infatti - come sopra ricordato - il 13 Ottobre 1527.
Gli antichi Annali dell’Archivio della casata forniscono un’ulteriore conferma della data di morte del conte Cesare: a partire dallo stesso 13 Ottobre 1527, negli atti che regolavano gli affari di famiglia al posto del conte Cesare compaiono il di lui primo figlio maschio allora già maggiorenne (indicato come quondam conte Cesare) e la moglie Ippolita (indicata vedova del quondam conte Cesare) tutrice dei figli minorenni. Un altro particolare risulta inequivocabile: per questioni dotali concernenti tre delle figlie del conte Cesare, tra il 1529 e il 1531, non compare il padre - essendo egli deceduto - ma al suo posto agisce il di lui figlio maschio primogenito.
La morte del conte Cesare non può dunque essere in nessun modo collocata nell’anno 1551, menzionato dalla pubblicazione di cui sopra.
Ci si domanda pertanto cosa derivi da una tale discrepanza cronologica.
Ne deriva che si debba pensare a una diversa datazione del dipinto, ben lontana dal periodo attorno al 1550 menzionato dalla fonte in questione, a meno che esso sia ritenuto un'opera eseguita molto dopo la morte del soggetto, per sua commemorazione: ma questo è un fatto che, allo stato attuale delle conoscenze, non è suffragato da documento alcuno.
Si deve notare che la morte del conte Cesare nell’anno 1551 era stata in precedenza citata da un’altra pubblicazione, apparsa nel Giugno 1908 (poco dopo l'ingresso del dipinto del Romanino nella Pinacoteca di Brera). (Nota 9)
Verosimilmente la prima pubblicazione ricordata nel presente articolo, apparsa nel 1965, aveva tratto spunto da quest’ultima, del 1908.
La pubblicazione del 1908 aveva però concluso una cosa ben diversa. Ossia che il dipinto del Romanino fosse stato eseguito quasi certamente attorno al 1527, dopo la partecipazione di Cesare Martinengo all'impresa di Francesi e Veneziani contro Genova conclusasi con la resa della città.
La pubblicazione lasciava intendere quindi che l'Artista avesse creato un'opera in un certo modo “commemorativa”, atta a porre in evidenza il ruolo giuocato dal conte Cesare Martinengo in quelle azioni militari, per le quali avrebbe anche ricevuto un'importante ricompensa.
La pubblicazione si rifaceva, senza però dirlo in modo esplicito, a un passo dall'opera apparsa nel 1860 con il titolo Storie Bresciane dai primi tempi sino all'età nostra, di Federico Odorici, il quale aveva infatti scritto:
«Cesare Martinengo, valentissimo capitano, cui fu dovuto in gran parte l'acquisto di Genova, che nell'autunno del 1527 facevano l'armi veneziane e le francesi, per cui venne, col Fregoso capo di quella fazione, dalla Repubblica rimunerato.» . (Nota 10)
L'unica differenza tra la pubblicazione del 1860 e quella del 1908 è che in quest’ultima non veniva menzionato l'autunno del 1527, forse o probabilmente perché l’autore che l’aveva scritta sapeva che la spedizione franco-veneta contro Genova e la resa della città erano state precedenti (estate 1427).
Vale la pena di soffermarsi su un elemento molto importante inserito nel ritratto del Romanino, che confermerebbe la ricostruzione secondo cui esso sarebbe stato eseguito in seguito alla significativa partecipazione del conte Cesare Martinengo ai fatti della resa di Genova: il conte Cesare Martinengo sfoggiava la sontuosa collana d'oro con medaglione recante l'emblema di San Marco, testimonianza, o simbolo, di prestigio politico e militare presso la Serenissima.
Stando alla datazione del quadro fissata dalla pubblicazione del 1908, il 1527, il conte Cesare Martinengo avrebbe avuto attorno ai cinquant'anni.
La pubblicazione del 1908 propone però una descrizione del ritratto del conte Cesare Martinengo che si sofferma sulla di lui fisionomia insistendo sui segni della di lui età avanzata: la pelle giallognola, le carni leggermente anemiche [...] le orecchie senza sangue e quasi membranacee.
Sono considerazioni che non paiono convincenti analizzando il ritratto.
Anzi, esse paiono contraddittorie rispetto alle capacità che il conte Cesare Martinengo aveva dimostrato negli eventi militari ai quali aveva partecipato nell’estate del 1527 e la cui eco sarebbe stata all’origine del ritratto del Romanino secondo la stessa pubblicazione. Viene da domandarsi una cosa semplice: come sarebbe stato possibile che un uomo dai segni di vecchiaia fisica già tanto accentuati potesse avere combattuto, distinguendosi, in una siffatta impresa?
Si deve allora valutare l’attività del conte Cesare Martinengo sino alla sua morte, come si ricava dalla documentazione dell’Archivio della casata. Si comprende come egli fosse invece energico e vitale. Del resto, il suo decesso - poco tempo dopo le azioni militari contro Genova - sarebbe avvenuto in modo del tutto inatteso, per un’improvvisa, aggressiva malattia, contratta durante le sfarzose nozze di una delle sue figlie, che da essa furono funestate.
La ricostruzione proposta dalla pubblicazione del 1908, tesa a individuare il motivo storico-politico-militare che sarebbe stato all'origine del ritratto del Romanino, comporta verifiche anche nell’Archivio della casata.
Si deve prima di tutto accantonare la datazione degli eventi di Genova (che avevano visto la determinante partecipazione di Cesare Martinengo) all’autunno 1527, ricordata da Federico Odorici.
Si deve valutare lo spazio temporale intercorrente tra gli eventi di Genova, che sono invece da collocare nell’estate 1527 e la morte di Cesare Martinengo, avvenuta il 13 Ottobre 1527.
Esaminando l'Archivio della casata si ricavano alcune tracce interessanti: i primi di Luglio 1527 veniva rogato l'atto di patto matrimoniale di una delle figlie del conte Cesare Martinengo, che si obbligava a pagare una notevole dote; il 30 Agosto 1527 egli faceva un acquisto di terre nel Bresciano. Si può pertanto ritenere che la partecipazione di Cesare Martinengo alla spedizione franco-veneta contro Genova si fosse collocata entro quell’arco temporale, nel quale egli non appariva come protagonista in prima persona nelle attività della gestione della casata.
Occorre allora valutare una tale ipotesi alla luce degli avvenimenti storico-politici-militari.
Genova, da tempo occupata dall'esercito spagnolo, stipulata la Lega di Cognac e costituita una spedizione francese e veneziana, assediata per mare e per terra, veniva presa nel mese di Agosto 1527. Per precisione, il comandante vittorioso della spedizione francoveneta contro Genova, che si era resa, entrava nella città il 18 Agosto 1527. (Nota 11)
Come fatto notare poc’anzi, basandosi sugli atti registrati dall’Archivio della casata il conte Cesare Martinengo non risultava personalmente attivo a Brescia in tale periodo. Egli poteva dunque effettivamente avere partecipato agli eventi militari portati contro Genova.
Tra la metà di Agosto circa e il 13 Ottobre 1527, decesso del conte Cesare Martinengo, intercorsero due mesi circa.
In questo computo si deve inserire il rientro a Brescia del conte Cesare Martinengo e molto verosimilmente il suo ulteriore viaggio a Venezia. Deduciamo dall’Archivio della casata che egli aveva sicuramente preso a condurre le proprie attività personali il 30 Agosto. Il suo decesso sarebbe avvenuto circa sei settimane dopo.
Considerando il contesto, non pare plausibile che un quadro eseguito da una personalità artistica quale era Il Romanino, un ritratto tanto importante, accurato nell'esecuzione sino ai più minuti dettagli, come la morbida pelle del guanto che lascia emergere le articolazioni della mano e il movimento delle dita, raffinato nei particolari dell'abbigliamento, in special modo nella resa dell’avvolgente pelliccia e delle guarnizioni sempre di pelliccia di straordinaria fattura, che lasciano intuire la presenza di un’intera fodera di pelo atta a riscaldare il busto del conte Cesare, possa essere stato commissionato e portato a termine in tale breve lasso di tempo.
Analizzando i dettagli fisionomici che il ritratto del Romanino delinea con tanta ricchezza di particolari, a cominciare dalle linee delle rughe d’espressione sulla fronte e dal disegno dell’arco delle sopraciglia, ci si sente però di affermare che il conte Cesare Martinengo dovesse essere in vita almeno al momento dell’esecuzione dei tratti fondamentali del suo volto e della sua persona fisica.
In conclusione, la data del ritratto deve essere ancora indagata e individuata.
In tal senso non sembrerebbe possibile trovare una strada che conduca a un traguardo convincente neppure esplorando il magnifico libro di Amedeo Quondam su moda e cultura del gentiluomo del Rinascimento, sulla moda del nero nell’abbigliamento maschile del tempo. (Nota 12)
È importante far presente che le ricerche finalizzate a trovare una traccia della committenza artistica del ritratto del conte Cesare Martinengo al Romanino, compiute all’interno del vasto Archivio della casata, non hanno sino ad ora dato risultato positivo.
Occorre anche osservare che negli Inventari di Beni tenuti dalla casata (risalenti al pieno Diciassettesimo secolo) non è registrato - con una descrizione inconfutabile – il quadro del Romanino, come invece si riscontra per i ritratti di tre dei figli maschi del conte Cesare Martinengo stesso: i ritratti di Giorgio, di mano del Romanino, di Fortunato, di mano del Moretto, e di Ottaviano, sempre di mano del Moretto.
Si apprende solo dell’esistenza del ritratto del conte Cesare detto “Vechio”, senza altre informazioni. Non pare verosimile che il nome di un autore quale il Romanino venisse omesso. Inoltre, il nome Cesare si ripropose nelle generazioni dei Martinengo con regolarità: esaminando gli Inventari di Beni del Diciassettesimo secolo non si può dunque dedurre con certezza a quale dei Cesari delle generazioni precedenti venisse dato l’appellativo di “Vechio”. Si potrebbe addirittura pensare che si trattasse del ritratto del primo Cesare della casata, vissuto nel Quindicesimo secolo, di cui sopra, forse dipinto da un artista del quale si era perduto il nome con lo scorrere delle generazioni?
In ogni caso è utile far notare che i quadri elencati nei citati Inventari di Beni seicenteschi, al di fuori del ritratto del conte Cesare Martinengo e di quello del figlio Fortunato Martinengo, non risultano oggi individuabili né si conosce il luogo dove essi sono oggigiorno tenuti.
A questo punto è opportuno sottolineare che la casata, nel pieno Seicento, epoca dei citati Inventari di Beni, aveva oramai assunto il cognome costituito dai due elementi Martinengo Cesaresco.
Si deve ora dedicare qualche parola d’informazione su come mai e quando il quadro del Romanino, raffigurante il conte Cesare Martinengo, sia pervenuto alla Pinacoteca di Brera.
A quanto risulta questo quadro era stato venduto nel 1906 da un membro della casata Martinengo Cesaresco.
Il venditore discendeva da uno dei rami familiari che erano derivati dagli unici due figli maschi del conte Cesare Martinengo e della contessa Ippolita che avevano dato progenie vivente, proseguendo la stirpe: essi erano Gio. Antonio («Annibal sive Jo. Antonius»; nei documenti dell'Archivio della casata veniva per lo più chiamato Antonio), nato nel 1521, e Lelio, nato nel 1524.
Il venditore discendeva dal ramo originato da Lelio. (Nota 13)
Trascorsi i secoli, al momento della vendita il quadro era tenuto in una proprietà fuori Brescia, in una località che da sempre faceva parte dei possessi della casata.
Sembra che il venditore - che come accennato portava oramai per cognome quello di Martinengo Cesaresco - non avesse inizialmente compreso il valore del quadro stesso. Solo dopo la vendita la sua eccezionale qualità e importanza erano infatti venute a chiarirsi. Solo dopo averlo ceduto egli si sarebbe dunque reso conto del terribile errore che aveva commesso. Sembra anche che, di conseguenza, egli cercasse di impugnare il contratto di vendita nel tentativo di riottenerlo. Ma nulla egli poté fare.
In sintesi, la storia della vendita fu la seguente.
Dapprima il quadro era stato venduto a un collezionista di Venezia. Poi esso era passato nelle mani di un ulteriore acquirente, a Milano, a un valore pecuniario di molto superiore. Infine, dopo l'opera di pulitura e restauro, esso venne attribuito da parte della Commissione Nazionale di Belle Arti a Girolamo da Romano detto Il Romanino.
Fu allora che il Governo lo acquistò, nel Dicembre 1907, per una notevole somma. Ed esso trovò posto nella Pinacoteca di Brera. (Nota 14)
Note al Testo
NOTA 1
Monsignor Paolo Guerrini, Una celebre famiglia lombarda. I conti di Martinengo, Litografia F.lli Geroldi, Brescia, 1930, p. 413.
Anche sul decesso del conte Cesare Martinengo nel libro di Monsignor Guerrini vi è un'inesattezza: egli scriveva infatti, p. 414, che essa cadde il 3 Ottobre 1527.
NOTA 2
Si veda ad esempio il sito web che pubblica Ritratto di gentiluomo (Cesare Martinengo Cesaresco), 1540 ca., olio su tela. Anche il cognome ‘Martinengo Cesaresco’ non è corretto in quanto, come si dirà nel presente articolo, all’epoca del conte Cesare il cognome in uso era esclusivamente ‘Martinengo’.
Si deve far notare che, al momento della stesura del presente articolo, sono state rilevate numerose inesattezze, anche gravi, presenti nelle pagine online su Wikipedia riguardanti la casata.
Numerose le inesattezze presenti nelle voci Treccani.
Le informazioni derivano infatti sostanzialmente da una fonte originaria, in special modo Una celebre famiglia lombarda. I conti di Martinengo, il cui autore non ebbe modo, prima della consegna alle stampe della propria opera, di consultare approfonditamente l’Archivio della casata.
Il dipinto misura cm. 97 x 78, secondo la pubblicazione del 1908, p. 1, a seguire citata, mentre misura cm. 100 x 77, secondo il catalogo 1965, p. 135, a seguire citato.
NOTA 3
Si veda la nota n. 15 (pp. 21 - 22) del saggio dedicato a Fortunato Martinengo firmato dagli autori del presente articolo, visibile in questo Sito cliccando nell’area dell’immagine del suo ritratto, opera di Alessandro Bonvicino detto Il Moretto: il titolo del volume che lo contiene è Fortunato Martinengo. Un gentiluomo del Rinascimento fra arti, lettere e musica, Editrice Morcelliana, Brescia, 2018, pp. 17-50.
NOTA 4
Si veda nel saggio Fortunato Martinengo. Un gentiluomo del Rinascimento fra arti, lettere e musica, cit., pp. 22 - 23 e la nota n. 19.
NOTA 5
Girolamo da Romano detto Il Romanino: nato a Brescia tra il 1484 ed il 1487 e morto dopo il 1562.
NOTA 6
L'incisione reca: Cesare Martinengo Co. 1509.
Incisori: Paolo Maria e Andrea de Abbiatis. Serie databile alla seconda metà del Seicento (alcune incisioni recano nella didascalia l'anno 1661).
In questo Sito, nella sezione Engravings, è pubblicata tale incisione. Si sottolinea il fatto che in essa, oltre a essere riportato l’anno 1509, Cesare Martinengo è qualificato Co. (conte), ciò che fa ritenere che l’incisione si riferisse all’evento fondamentale della titolatura di conte da parte di Luigi XII di Francia.
NOTA 7
Mostra di Girolamo Romanino, Catalogo, a cura di Gaetano Panizza, Brescia 1965, p.135.
NOTA 8
Si deve precisare che nessuno degli altri membri della casata che ebbero per prenome Cesare morì nel 1551.
NOTA 9
Le strane vicende d'un ritratto del Romanino, Illustrazione Bresciana, Anno 7, N. 116, 16 Giugno 1908, pp. 1-2.
L’autore di questa pubblicazione precisava che le informazioni biografiche sul conte Cesare Martinengo (che veniva erroneamente chiamato con il doppio cognome Martinengo Cesaresco) erano state tratte dallo studioso di cose bresciane Monsignor Luigi Francesco Fè d'Ostiani.
NOTA 10
Federico Odorici, Storie Bresciane dai primi tempi sino all'età nostra, Tipografia Gilberti, Brescia, 1860, Vol. 9, p.183.
NOTA 11
Venezia aveva aderito alla Lega antiasburgica di Cognac. Nell'estate del 1527 perveniva in Italia l'esercito francese al comando di Odet de Foix visconte di Lautrec. Alla metà di Agosto, a Cesare Fregoso, che dal 1524 aveva ottenuto da Venezia ruoli di comando, venne affidato quello della spedizione francoveneta contro Genova, stretta nel contempo dal mare dalle flotte di Pedro Navarro e di Andrea Doria. Cesare Fregoso il 18 Agosto 1527 entrava a Genova; egli avrebbe ricevuto ingenti somme in premio.
Si vedano le voci presso Treccani.it: FREGOSO (Campofregoso) Cesare, Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 50 (1998); DORIA, Filippo (Filippino), Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 41 (1992).
NOTA 12
Amedeo Quondam, Tutti i colori del nero, coll. Rinascimenti, Angelo Colla Editore, Costabissara (Vicenza), 2007.
NOTA 13
Per precisione è utile dire che dal bisnipote di Lelio derivarono ulteriori tre "sottorami" che si svilupparono a partire dalla seconda metà del Seicento attraverso tre maschi: dal "sottoramo" che si formò dal minore di quei tre maschi, nato nel 1684 e morto nel 1759, sarebbe disceso il venditore del quadro del Romanino.
Costui, di cui per riservatezza non si menziona il nome, nacque nel 1851 e morì nel 1938.
NOTA 14
Le strane vicende d'un ritratto del Romanino, 1908, cit., p. 2.
|